Storie di un fotografo
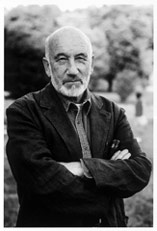 |
|
Gianni Berengo Gardin
© Colombo D’Apolito |
Albergo in riva al mare, esterno giorno, una domenica mattina, a colazione. Cittadina meridionale, piena estate, ambiente caloroso. Un festival tra i più importanti in Italia, l’autore da molti considerato il più rappresentativo tra i fotografi italiani. Gianni Berengo Gardin non ha una sua mostra quest’anno a Corigliano Calabro (www.coriglianocalabrofotografia.it), ma è qui come sempre dalla fondazione della rassegna undici anni fa, a vedere e respirare fotografia, a intervenire e curiosare, a guardare le altre mostre e incontrare gli altri autori, ad accompagnare gli amici organizzatori (Gaetano Gianzi, Cosmo Laera, Giorgio Tricarico, Francesco Vitali Salatino). L’occasione giusta per una conversazione di quasi un’ora, attorno a cinquant’anni di attività fotografica, quasi un’autobiografia, sincera e senza sconti, dalla formazione ai successi, dai maestri ai libri, dalla pellicola all’ondata digitale, dalle scelte di linguaggio al mercato, dal privato alle migrazioni e ai viaggi.
Milano sta dedicando una grande retrospettiva (a cura di Denis Curti, a Palazzo Reale fino all’8 settembre) alla tua fotografia in bianco e nero.
La mostra di Milano è composta dalle centoventi foto esposte alla Casa dei Tre Oci di Venezia più quaranta foto su Milano. Ho aggiunto una sezione sulla serie sui manicomi in Italia e una sul lavoro sugli zingari. Sono diventate in tutto centottanta circa, una bella mostra. A Venezia era in un posto bello luminoso mentre a Milano c’è molta illuminazione artificiale perché non ci sono praticamente finestre. Poi c’è il catalogo nuovo, pubblicato da Marsilio (280 pp., 184 foto, 40 euro, ndr). E a Venezia è stato un successo insperato per me perché la mostra precedente era quella di Elliott Erwitt: hanno venduto più cataloghi della mostra di Erwitt e hanno fatto il doppio di entrate di Erwitt. Sai, Erwitt è conosciuto dagli addetti ai lavori e non dal grosso pubblico. Io sono conosciuto dai fotoamatori, la mia fortuna sono i fotoamatori.
Che sono cresciuti come gusto?
Sono cresciuti così così. Per esempio, l’altro giorno con Mario Dondero abbiamo fatto insieme un incontro a Tolentino e c’era la sala piena, saranno state trecento persone. A un certo momento ho chiesto “Chi tra voi conosce August Sander?” Silenzio assoluto, una mano si è alzata. Purtroppo molti fotoamatori non amano la fotografia, amano la loro fotografia. Guardano la loro fotografia e non gliene frega niente delle altre, rimangono limitati al loro gruppetto. Mentre, a noi che amiamo la fotografia, interessa vedere la fotografia degli altri, noi viviamo di fotografia.

© Gianni Berengo Gardin, Lido di Venezia 1959
Questione di cultura fotografica.
D’accordo, i libri costano caro, indubbiamente. Però i circoli fotografici se le dividono le spese. A parte Cartier-Besson che lo conoscono anche i sassi, ma già quando parlo di Paul Strand proprio nessuno sa chi sia, nessuno sa che ha fatto un paese con Zavattini, Luzzara, che io ho fatto vent’anni dopo. C’è questa ignoranza. Poi adesso col digitale è andato tutto in vacca perché il digitale cambia la mentalità dei fotografi che scattano a mitraglia, a mitraglia proprio, e poi non guardano nemmeno, tanto se vengono brutte poi le si salva con Photoshop. Io Photoshop, per il reportage, non per la moda o la pubblicità, lo abolirei per legge, perché falsa la comunicazione. È quello il grave, che non è più una comunicazione onesta, perché ormai tutte le foto di paesaggio in digitale hanno i cieli tempestosi. A parte che il digitale non mi piace perché è freddo, è metallico, però può essere una scelta. I due unici vantaggi reali del digitale sono l’immediatezza (fai una foto adesso e il minuto dopo è a New York) e la possibilità di cambiare impostazioni secondo le condizioni. Ma tolti questi due vantaggi? Sì, il digitale è più inciso della pellicola. Ma la pellicola è più plastica. E poi la cosa gravissima è che non esisteranno più gli archivi, perché tra cinque, dieci anni cambieranno i mezzi di lettura. Io ho dei cd che sono diventati vecchi, illeggibili, e poi ho dovuto cambiare computer, stampante, anche se io in digitale stampo pochissimo, solo quando ho un’urgenza. Io sono un fanatico della pellicola. E poi mi dicono i galleristi americani che ormai i collezionisti non comprano più stampe in digitale, vogliono i sali d’argento e quindi io continuo a stampare con i sali d’argento.
Dunque il digitale non lo hai usato mai?
No, mai. Anzi, una foto. Una su un milione e cinquecentomila.
E quale?
È esposta anche a Milano. La Leica, a suo tempo, mi aveva dato da provare la Monochrom, l’ho provata e in effetti ha una resa eccezionale. Però a me l’idea della postproduzione... O sei bravissimo a farla tu, e ti costa una follia di tempo (noi non calcoliamo mai il tempo che ci vuole dopo) o la dai da fare fuori e ti costa altrettanto. Invece il mio stampatore, ormai, sa da vent’anni come le voglio. E me le stampa come voglio io. E quindi io continuo con la pellicola.
La grande ondata digitale non ti ha sfiorato.
La grande ondata digitale è soprattutto in Italia. In Francia, in America non è così di moda il digitale. Però professionisti seri usano ancora le macchine analogiche: Francesco Cito usa pellicola, Ivo Saglietti usa pellicola, Ferdinando Scianna usa secondo necessità pellicola o digitale. Pare che siamo delle bestie rare, invece siamo ancora tantissimi. Poi in America il banco ottico spopola ancora. Pensa che in Italia una rivista di fotografia tira 10 mila copie e ne vende 4 mila quando va bene. In America ci sono sei riviste che tirano ciascuna 100 mila copie, tutte e sei di bianco e nero solamente. Quindi vuol dire che c’è pubblico. Anche in Francia la pellicola va ancora tantissimo.

© Gianni Berengo Gardin, Lido di Venezia 1958
Vorrei farti una domanda sul linguaggio. Ma tu cosa cerchi ancora?
Il racconto cerco, il racconto. Ci sono due tipi di fotografia che raccontano. Una, chiamiamola alla Cartier-Bresson tra virgolette: una foto unica che però racconti qualcosa. L’altra, il racconto con cento foto, quindi più dilazionato, per fare un libro.
Un progetto…
Un progetto c’è sempre. Certo se passo per strada e vedo una foto interessante, non c’è progetto; ma in linea di massima sì. Adesso a gennaio, con Contrasto, esce il mio libro dei libri, con i duecentocinquanta libri che ho fatto, come un riassunto diciamo, e quasi tutti i libri nascono da un progetto, l’80% progetti miei, il 20% progetti che mi hanno commissionato.
Qual è un progetto tuo che ti è rimasto dentro, a cui tieni particolarmente? E poi un esempio di progetto commissionato?
Di progetto commissionato, il più importante è Morire di classe, realizzato su commissione di Basaglia. Un altro importante progetto commissionato è quello sugli zingari, che è stato sponsorizzato da Bruxelles. I sindaci italiani non lo sanno, ma Bruxelles mette a disposizione dei sindaci mi sembra 20 mila euro per fare una pubblicazione su una minoranza locale. A Firenze la minoranza erano gli zingari e mi hanno sponsorizzato gli zingari. Ho vissuto un mese e mezzo insieme a loro e li ho capiti. Sugli zingari ero pieno di pregiudizi e preconcetti, come tutti gli italiani, che poi ho smontato perché è gente eccezionale. Sono di una generosità, quando ti diventano amico, hanno delle musiche bellissime, hanno poeti, scrittori. Certo, alcuni rubano, ma sono una minoranza. A Firenze tutti i giardinieri del comune sono zingari e nessuno lo sa. A Reggio Emilia in un campo c’erano trentacinque donne che non volevano farsi fotografare. Avevo già fatto cinque o sei campi e le donne si erano sempre fatte fotografare. E allora non capivo perché. Poi, una mi ha spiegato: “Noi andiamo tutte a servizio da famiglie italiane; se queste scoprono che siamo zingare il giorno dopo ci licenziano”.

© Gianni Berengo Gardin, Milano 2005
Torniamo ai progetti nati da te.
Progetti miei ce n’è un’infinità: sull’India, per esempio. Sono stato diverse volte e a lungo nei villaggi indiani, solo nei villaggi, perché da ragazzo ero un fanatico di Gandhi e una frase famosa di Gandhi più o meno dice: voi europei quando venite in India andate a Bombay, a Calcutta, nelle grandi città e invece la vera India è nei villaggi.
L’80% degli indiani vive nei villaggi, o almeno viveva.
Si vivevano, adesso è cambiato tutto. Sono andato da turista anche nelle grandi città, ma ho vissuto nei villaggi, è stato bellissimo. E poi altri progetti, tanti. L’ultimo, pubblicato da Contrasto un mese fa, su una grande cascina del vercellese che produce riso. Hanno mantenuto tutte le tradizioni, ci sono ancora i dormitori delle mondine come una volta, c’è la scuola interna, l’officina, la selleria, è molto bello, ho fatto un librone grosso.
E questo l’hai pensato tu. Come trovi gli spunti, le idee? Leggendo, guardando, ascoltando?
Leggendo. Di solito i fotografi dicono: mi ha ispirato quel quadro. A me i quadri non hanno ispirato niente, solo leggendo.
Da giornalista.
Sì, da fotogiornalista. Poi certe volte mi sveglio di notte con le idee, e poi il giorno dopo...
Idee o progetti in programma?
Non ho assolutamente niente perché sono stanco in questo periodo. Uscirà il libro dei miei libri, poi un altro libro che ho fatto sul Caffè Florian, una mia idea perché frequento il caffè da tanti anni, perché lì ho degli amici. Ogni volta che vado a Venezia vado al Florian, da ex veneziano c’ero legato. Un giorno ero lì, è successa una scena carina con dei bambini, così ho detto a un mio amico del Caffè: “Perché non facciamo una cosa sul Caffè?”. E lui mi ha risposto: “Sì, facciamola”. Uscirà in ottobre un libretto con trenta quaranta foto, stampato da Marsilio.

© Gianni Berengo Gardin, Milano anni settanta
Uscite su uscite.
Beh, se calcoli che ho fatto duecentocinquanta libri in cinquanta anni. Ma io all’inizio ho fatto i libri per disperazione, perché i giornali non mi facevano lavorare, dovevo mantenere la famiglia. Ho spostato l’attenzione sui libri perché con gli sponsor che sponsorizzano i libri bene o male…
Ma li hai conservati tutti?
No, ma c’è il direttore della biblioteca di Le Mans, in Francia, che ha curato il libro dei miei libri, che ne ha almeno venticinque più di me che non mi ricordavo nemmeno di aver fatto. Sono duecentocinquanta, ma di importanti ce ne saranno cinquanta, ci sono tante cose commerciali.
Il rapporto con i giornali qual è o qual è stato?
Nessuno, solo agli inizi ho lavorato un po’ per Panorama. Lavoravo un po’ per dei giornali stranieri, ma io non parlo inglese e allora era complicato. Parlo francese, invece, perché ho abitato per due anni a Parigi da ragazzo. La mia fotografia è molto influenzata da quella francese perché ho conosciuto Boubat, Doisneau e soprattutto Willy Ronis. Con lui eravamo molto amici, ci frequentavamo molto. Mi ha molto influenzato. Dicono che sono il Cartier-Bresson italiano, ma in realtà sono il Willy Ronis italiano. Mi ha influenzato, proprio all’inizio, perché c’era un librettino tradotto in italiano, dal titolo Come diventare fotoreporter, fatto da lui. Poi l’avevo conosciuto già a Venezia perché ogni anno veniva una settimana in vacanza con la moglie. E quindi l’ho frequentato a Parigi. Poi ho avuto un colpo di culo spaventoso, perché avevo uno zio in America che era molto amico di Cornell Capa, il fratello di Capa, che non dirigeva ancora la ICP però era già dell’ambiente. E questo zio gli ha detto: “Sai io ho un nipotino che si interessa di fotografia; che libri mi consigli di mandargli?”. Per questo, anche, sono un maniaco di libri. Ho tremila libri di reportage, che adesso diventano un peso perché nessuno li vuole. Non so se fare una donazione, ma io vorrei anche un po’ di soldi. Tornando a Capa gli ha consigliato dei libri di fotografi di Life, di Dorothea Lange, soprattutto di W. Eugene Smith che è stato il mio idolo fin dall’inizio e lo è rimasto tutt’ora. Mi ha mandato questi libri e così ho avuto il vantaggio di vedere tutti i fotografi americani anche prima degli italiani, sono partito avvantaggiato rispetto ad altri.

© Gianni Berengo Gardin, Milano 1959
Di quali anni parliamo?
Del 1954, grosso modo. Fino al allora ero un fotoamatore, facevo delle belle fotografie cretine. Ma quando ho ricevuto questi libri sono cambiato da così a così, perché ho capito che la fotografia poteva non essere un passatempo, ma un impegno, un lavoro serio. Un lavoro sociale, soprattutto, perché allora ero comunista. Lo sono ancora adesso, non so bene se comunista o cosa, diciamo di estrema sinistra. Ho fatto questo passaggio in quattro giorni! E da allora ho deciso di diventare professionista. Ho detto: “Cavolo, si può fare un lavoro serio, bello”. Se non avevo questo zio in America ero ancora nel negozio di vetri di Murano dei miei a Venezia.
Il tuo zio d’America sono stati dei libri.
Si sono stati questi quattro, cinque libri iniziali che mi hanno cambiato la vita. E poi un personaggio importantissimo che nessuno conosce, Romeo Martinez. Era il direttore della rivista di fotografia Camera che pubblicavano a Basilea, allora la più importante rivista di fotografia del mondo. Lui era il più importante conoscitore della fotografia mondiale, amico intimo di Cartier-Bresson, di W. Eugene Smith e altri personaggi importanti, e veniva a Venezia a organizzare le prime biennali di fotografia. Una sera, passeggiando, lui usciva dal Casinò al Lido, io abitavo al Lido, parlando del più e del meno, mi ha detto: “Ma cosa aspetti a diventare professionista?”. Io gli ho detto: “Tu sei matto che divento professionista, ho un negozio che guadagna bene, ho una moglie, due figli, con cosa li mantengo?”.
Quanti anni avevi?
Avevo ventotto anni. E lui mi ha detto: “Sono sicuro che ce la farai”. E io mi sono fidato. Il giorno dopo sono partito per Milano, ho preso una camera in affitto e per due, tre anni ho fatto il pendolare con Venezia. Il negozio lo gestivo io, era dei miei genitori e delle sorelle ma erano tutti morti. Con i soldi che ho preso vendendo il negozio ho detto: “Per tre, quattro anni sto tranquillo che da mangiare c’è”. Per quegli anni avevo il panino da dare ai figli. Quindi ho cominciato, ho fatto la gavetta a Milano, ho fatto di tutto i primi due anni, compresi i matrimoni. Ho fatto una cosa che oggi non si potrebbe più fare: per Panorama ho fatto una rubrica che si chiamava “I più bei bambini nelle spiagge italiane”, andavo in giro a fotografare i bambini e le mamme erano tutte contente. Ho fatto due anni così poi sono riuscito a incanalare il mio lavoro industriale, Olivetti, IBM, Italsider. Eravamo negli anni del boom e poi non c’era la concorrenza dei telefonini. Oggi, ormai anche gli industriali si fanno fare le foto dal nipote con il cellulare. E quindi mi è andata bene.

© Gianni Berengo Gardin, Piazza San Marco, Venezia 1959
Ti sei spostato molto, sei un migrante.
Sì. Il mio giro è stato: Santa Margherita Ligure; poi Roma sette, otto anni; poi Venezia; poi Parigi; poi Losanna. Parigi e Losanna come migrante perché non avevo una lira. Perché mio padre, quando avevo diciassette diciotto anni, mi ha detto: “O studi” – non come adesso che si mantengono i figli fino a quarant’anni – “e ti mantengo, o se no vai a lavorare”. Sono andato a Parigi a fare il cameriere per due anni, poi ho lavorato alla reception di un grande albergo. Avevo il vantaggio che lavoravo dalle sette di mattina fino a mezzogiorno, avevo tutto il pomeriggio libero. A venticinque anni a Parigi non potevo chiedere altro dalla vita. E quindi fotografavo tutti i pomeriggi praticamente. Ho fatto tante belle foto di cui poi sono andati persi i negativi, nel trasloco da Venezia a Milano, ne ho salvati pochissimi. Poi dopo Parigi, Losanna, poi un’altra volta Venezia e poi Milano. E a Milano mi sono fermato.
Se uno ti dovesse chiedere di dove sei, di quale luogo ti senti se ce n’è uno? Hai un’identità multipla.
Sì, un’identità multipla. Quelli che hanno più influito sono stati soprattutto i due anni a Parigi, perché c’era una mentalità completamente diversa dall’Italia. Figurati che nel 1954 in Italia per andare in vacanza in Spagna, oltre al visto sul passaporto, dovevi avere il benestare del parroco della tua parrocchia, se no in Spagna non andavi. Tornando all’identità, Parigi e poi Venezia, io oggi non mi sento più ligure, mi sento forse veneziano e ormai milanese. Ma più di tutto per la mia formazione hanno contato Parigi e Venezia. Ora abito a Milano, in una casa-studio. Sono andato avanti anni, facendomi ogni mattina tre quarti d’ora di macchina per andare da un capo all’altro di Milano, poi basta. Ho avuto una grande sala posa perché lavoravo per l’Alfa Romeo, con le macchine e i camion, ma è durato pochissimo, un anno o due. Lavoravo ventinove giorni al mese per pagare le spese, gli assistenti, eccetera. E poi due giorni per me. Poi ho rinunciato, ho fatto casa-studio e adesso mi trovo benissimo.

© Gianni Berengo Gardin, Milano 1968
Il viaggio ti interessa?
Adesso non tanto, perché ormai non ce la faccio più, ma allora sì. Allora ogni mese stavo via dei periodi. Anche due, tre mesi di seguito.
E i conti con la famiglia come li facevi?
Malissimo. Sono un pessimo padre, se non avevo una moglie meravigliosa che tirava su i miei figli, ero uno sconosciuto. Mi ha sempre sostenuto, anche troppo e io ne ho approfittato un pochino, ero un poco bricconcello. Poi mi sono pentito, devo dire ho dei rimorsi di coscienza terribili nei riguardi di mia moglie. Ci siamo separati due o tre volte, ho avuto tre compagne diverse, e adesso son tornato con mia moglie, proprio per i rimorsi di coscienza, sono stato una carogna come si suol dire.
Sai, c’è un libro di Neruda, la sua autobiografia, che si intitola “Confesso che ho vissuto”. Anche tu puoi dirlo.
Ammetto di esser stato una carogna.
Ma questo lo posso scrivere?
Sì, sì. Puoi scrivere tutto, non nego niente. È normale sbagliare nella vita, si fanno anche delle cose giuste, ma se ne fanno tante sbagliate. Beh, torniamo alla fotografia.

© Gianni Berengo Gardin, Firenze Campo nomadi 1993
Fai letture portfolio ogni tanto?
No, mi rifiuto di farle. Mai fatte una volta. Perché sono un dramma. Io non so con che coraggio fanno le letture del portfolio. Quando ti si presenta uno, magari ha delle porcherie. Se tu gli dici che ha delle porcherie, questo qua si demoralizza e magari può diventare un grande in seguito e quindi gli tagli le ali. Se gli dici che sono belle o troppo belle, basta, si monta la testa. E poi io non sono buono a giudicare le foto degli altri. Mi piacciono o non mi piacciono, ma non so perché mi piacciono o non mi piacciono. Quindi non son buono a insegnare. Ho fatto dei workshop con Cosmo Laera ad Alberobello, ma non sapevo insegnare. Bisogna essere portati. Mi telefonano continuamente e non oso dire di no, poverini, perché è un lavoro sociale anche quello. E allora vengono con i portfolio e io mi barcameno un po’ per non dirgli troppo bene o troppo male. Ma poi è talmente soggettivo il giudizio: vieni da me e ti dico una cosa, vai da un altro e te ne dice un’altra all’opposto. Secondo me l’unica cosa importante non sono i workshop, perché non impari niente, stai lì a chiacchierare, ma un corso di fotografia serio come nelle università americane o nella scuola di arti e mestieri che ha fatto Toscani a Zurigo. E vedere libri, cercare di capire perché hanno fatto certe foto.
E i festival? Partecipi ai festival?
Sì, hanno un senso, specie qua nel Sud che hanno pochi contatti, è un modo di unire delle cose piacevoli, delle scampagnate. Non impari quasi niente, però stai con i colleghi. Sai, ormai siamo dieci in Italia, siamo sempre quelli, gira e rigira, siamo diventati amici e allora incontri gli amici.
Il festival di Corigliano Calabro cos’è per te?
Corigliano è il piacere di venire, ci sono delle belle mostre, delle brutte mostre, fortunatamente sono più le belle. E vengo volentieri, come una vacanza, come interrompere il tuo lavoro, anche se il mio lavoro mi è sempre piaciuto. Ho fatto sempre quello che volevo, eccetto i primi quattro anni in cui mi sono fatto un culo così, non ho mai dovuto cercare lavoro. Non c’è niente di peggio che andare a pietire lavoro nelle redazioni dei giornali. Ho avuto sempre quello che mi piaceva, che mi interessava. E in più mi pagavano per farlo, che volevo più di così. Certo io non ho mai puntato ai soldi e adesso mi trovo male perché non ho una lira.

© Gianni Berengo Gardin, Milano 1986
Con la fotografia non si guadagna?
Guadagno bene per vivere, ma se domani smetto di fotografare, non dico che sono alla fame ma... Comunque il mio simbolo è W. Eugene Smith che è morto con 125 dollari in banca, io ne ho qualcuno di più, vivo bene però se smetto per una malattia o qualcosa, sono in braghe di tela. E questa è una politica che ho insegnato ai miei figli: vivere bene alla giornata ma non accumulare denaro. Che è completamente sbagliato. Quando sei giovane non ci pensi, è tutto facile. Ma quando sei vecchio, quando la gente non ti dà più lavoro, so’ cazzi amari come dicono a Roma.
Adesso, se guardi in prospettiva, c’è un desiderio particolare da qualche parte in te?
No, a me basta scattare. È proprio un fatto fisico. Io dico sempre, scherzando un po’, che non sono un artigiano ma un manovale della fotografia. Si pensa che i manovali facciano dei lavori materiali e basta, che non serva l’intelligenza. Una grande frase di Cartier-Bresson è stata “Voi credete di fare le fotografie con la macchina, ma in realtà le fate con la testa, con gli occhi e col cuore” è quella la grande verità. Digitale, pellicola, va tutto bene, ma se non c’è la testa...

Gianni Berengo Gardin e Antonio Politano, © Massimiliano Palumbo









